Simbolo di convivialità, gusto e italianità, la pasta è il piatto principe della dieta mediterranea nonché una delle pietanze più diffuse al mondo. Dal 1998 viene celebrata con una giornata interamente dedicata alla promozione e divulgazione delle sue straordinarie caratteristiche di prodotto salubre e gustoso.
Nella cultura occidentale, l’accostamento tra la pasta e l’Italia è talmente scontato da rendere spaghetti and co. delle vere e proprie icone dello stivale. Come spesso accade con prodotti di tal fatta, gli aneddoti abbondando. Ad esempio, lo sapevi che non è sempre stata un primo piatto? E che fu al centro di un memorabile pesce d’aprile della BBC?
Celebriamo insieme la Giornata Mondiale della Pasta con una carrellata di storie, fatti e curiosità da gustare al dente.
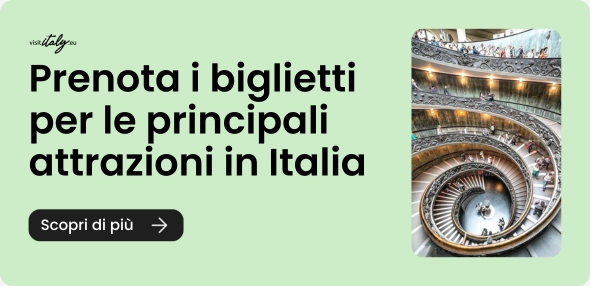
Giornata mondiale della pasta: origini della festa

Ogni anno il 25 Ottobre si festeggia la Giornata mondiale della pasta, un evento organizzato dall'Unione Italiana Food. La prima celebrazione ebbe luogo a Napoli nel 1998 e da allora si ripete ogni anno in diverse città in tutto il mondo.
Obiettivo: attirare l'attenzione sul ruolo globale ed unificante di un alimento dai molti pregi nutrizionali e dalle caratteristiche organolettiche uniche riconosciuto Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall'Unesco.
La Giornata mondiale della pasta nasce con l'intento di celebrare un prodotto sano, sostenibile, diffuso in tutti i continenti e in grado di soddisfare tutti i tipi di cucina, da quella sofisticata dei ristoranti di alto livello alla più semplice e casalinga.
Scopri come fare la pasta a RomaGiornata Mondiale della Pasta: miti e leggende di un simbolo

No, non fu Marco Polo a portare la pasta per la prima volta in Italia. La leggenda circola dalla prima metà del ‘900 e fu il Macaroni Journal (rivista dell’associazione dei produttori americani) ad elaborarla e pubblicarla per la prima volta nel 1929.
Sebbene inverosimile, la storia (una trovata di marketing?) riscontrò fin da subito un discreto successo, tanto da ispirare una scena de Le avventure di Marco Polo, film del 1938 con Gary Cooper. In breve, la vicenda narra di un marinaio dell’equipaggio del mercante veneziano, tale Spaghetti, che avrebbe appreso in Cina come preparare una pasta dalla forma lunga e sottile.
La base della diceria pare essere un passaggio de Il milione in cui Polo menziona un albero —verosimilmente la palma del Sago — dal cui frutto si ricava effettivamente un alimento alla vista simile alla pasta.
A proposito di alberi. Nel 1957 il programma Panorama trasmesso dalla BBC mandò in onda uno scherzo tanto ben congegnato che molti tra il pubblico lo ritennero veritiero. Il servizio, ambientato in Svizzera, mostrava degli alberi ricolmi di spaghetti allegramente raccolti da una famigliola di agricoltori.
Complice l’ancora scarsa conoscenza della pietanza, pare che il centralino dell’emittente venne subissato da telefonate di telespettatori incuriositi dall’“albero degli spaghetti”.
C’è da dire che durante il secolo scorso la letteratura, in particolare quella straniera, si è parecchio divertita a stuzzicare la fantasia di lettori e consumatori di pasta con storielle e consigli improbabili e a volte esilaranti la cui presa collettiva fu comunque clamorosa. Ad esempio, il trucco del lancio dello spaghetto contro il muro per verificarne la cottura è citato nel volume You Can Cook if You Can Read del 1946.
Scopri il workshop Pasta e Tiramisù a RomaCome si fa la pasta
Anzitutto, va distinta la pasta fresca da quella secca. Per la prima si utilizza farina di grano tenero ed è il più delle volte impastata, cotta e consumata al momento. La seconda prevede l’impiego esclusivo di semola di grano duro e va fatta essiccare perché duri più a lungo nel tempo.
Di forme e formati ne esistono a bizzeffe: paste quadrate, lunghe, arrotolate, a spirale o a conchiglia. In Italia si predilige corta e rigata, in America lunga; i francesi la consumano corta e liscia e in Germania la vogliono fresca.
Ve ne sono di progettate da illustri designer (si veda alla voce Philippe Starck) e di premiate con il Compasso d’Oro, il più autorevole premio al mondo nel campo del design. Per non parlare dei condimenti e delle infinite ricette a cui si presta. Insomma, due soli ingredienti di base (acqua e farina) per un’infinità di combinazioni.
Per quanto riguarda la pasta secca, il processo di lavorazione è semplice. Il primo step prevede la selezione del frumento, che è quindi setacciato, ripulito dalle impurità e macinato. Si ottiene in questo modo una semola che, unita all’acqua, dà vita all’impasto modellato dalle trafile, gli strumenti in bronzo o teflon che ne conferiscono la forma.
Il prodotto è trasferito quindi negli essiccatori, un passaggio delicato ed essenziale affinché la percentuale di umidità non superi il limite del 12,5% imposto dalla legge. A questo punto, una volta raffreddata, la pasta è pronta ad essere confezionata.
Scopri il Museo della pasta di ParmaLa storia della pasta
.jpg)
Sfatato il mito di Marco Polo, resta da chiarire dove e come nasca la pasta. Il dato certo è che il consumo in Italia si attesta a molto prima del ritorno dalla Cina del leggendario esploratore.
Dei bassorilievi su una tomba etrusca del IV secolo a.C. ( la “Tomba dei Rilievi” di Cerveteri) paiono raffigurare alcuni strumenti atti alla preparazione di una pietanza a base di acqua e farina simile alla pasta fresca.
Anche i Romani erano soliti consumare la lagana, una sorta di antenata della lasagna che veniva però servita come contorno insieme a carne, pesce o uova.
Tuttavia, è agli arabi che si deve l’invenzione della pasta secca, un prodotto particolarmente adatto a rimanere integro durante le traversate nel deserto.
Questo tipo di lavorazione prese piede dapprima in Sicilia nel XII secolo (il geografo Al-Idrisi scrisse nel 1154 della grande produzione di triyah nella regione) per poi diffondersi maggiormente con il rafforzamento delle rotte commerciali nel Mediterraneo.
Per quanto riguarda il termine pasta inteso come categoria merceologia, il primo testo in cui compare è a firma del viceré Giovanni d’Aragona, ma siamo già nel XVI secolo.
Testimonianze scritte circa la diffusione della pietanza in Italia si hanno già intorno al ‘200. In una delle prime — un atto notarile stilato a Genova nel 1279 — si legge di “una barisella plena de macaronis”.
Sempre allo stesso periodo risale la Cronica di Salimbene da Parma, dove il monaco francescano accenna ai tradizionali ravioli che consumava da ragazzo.
Come si prepara la pasta: breve viaggio nel tempo
Durante il medioevo la pasta diviene via via più popolare, comincia gradualmente ad essere considerata un vero e proprio piatto a se stante e a differenziarsi nei formati. A testimonianza della crescente diffusione, si annoverano numerosi riferimenti letterari.
Nel Decamerone ad esempio Boccaccio parla dell’immaginario paese di Bengodi, dove su di una montagna di parmigiano i cittadini cucinano maccheroni e ravioli. In effetti, proprio il formaggio è stato a lungo il principale condimento della pasta, anche se sulle tavole più facoltose non mancavano accostamenti ben più arditi e fantasiosi.
All’epoca, una portata a base di pasta aveva un aspetto e un sapore decisamente diverso rispetto ai piatti a cui oggi siamo abituati.
Tanto per cominciare, i tempi di cottura erano di molto superiori. Ci voleva circa un’ora per considerarla cotta al punto giusto: il concetto di “al dente” spopolerà soltanto a partire dal XIX secolo. Anche gli abbinamenti, poi, erano a dir poco sorprendenti e spesso prevedevano un mix di sapori dal dolce al piccante.
Di certo, era considerata una pietanza adatta agli abbondanti banchetti delle tavole nobiliari e all’estro degli chef più creativi. Personaggi come Bartolomeo Scappi, cuoco delle cucine vaticane le cui ricette sono ricordate per ricchezza e originalità.
I suoi maccheroni alla romanesca si preparavano a partire da un particolare impasto di farina, mollica di pane, latte di capra e tuorlo. Venivano successivamente bolliti per mezz’ora, ricoperti di formaggio grattugiato, burro, zucchero, cannella e provatura e cotti in forno con dell’acqua di rose.
Come si può notare, la gamma di sapori e ingredienti era estremamente varia e insolita. Col passare dei secoli, l’uso dello zucchero verrà accantonato e il “piatto nazionale” italiano assumerà gradualmente quell’aspetto e quei sapori riconoscibili da un commensale contemporaneo.
Solo nel XIX secolo si celebrerà finalmente il matrimonio perfetto tra la pasta e il suo condimento più famoso: la prima ricetta degli spaghetti al pomodoro risale al 1837.
La pasta a Napoli: una storia d’amore
Prima ancora di assurgere a simbolo di italianità, la pasta ha legato il suo nome alla città di Napoli. Tale era la sua diffusione all’ombra del Vesuvio che nel corso del ‘700 i napoletani vennero addirittura soprannominati “mangiamaccheroni".
Il successo della pasta in una città tanto sovraffollata e in cui le verdure (in particolare il cavolo) costituivano tradizionalmente l’alimento fondante nella dieta della popolazione è probabilmente dovuto all’introduzione del torchio, che velocizzò la produzione garantendo un’alta disponibilità a prezzi contenuti.
Di questa grande popolarità fu testimone Goethe. Durante il soggiorno a Napoli del 1787, il grande scrittore tedesco rimase sorpreso nel constatare come i maccheroni venissero venduti un po’ dappertutto e per pochi soldi.
Del resto la pasta conquistava proprio tutti, dai mendicanti (i cosiddetti lazzaroni) ai sovrani. Re Ferdinando IV ne era un avido consumatore e la mangiava direttamente con le mani senza l’uso di posate.
Certamente i numerosi pastifici della zona contribuirono a spingere la diffusione del prodotto. Il ‘500 e il ‘600 furono due secoli chiave per il boom della pasta secca, alimento estremamente versatile durante le carestie: si conserva a lungo, è economico e possiede un alto valore nutritivo.
In zone in cui la presenza d’acqua era copiosa sorsero prima mulini e successivamente pastifici a conduzione familiare. La cittadina di Gragnano ne è un esempio lampante: nel 1845 Ferdinando II di Borbone incaricò i pastai locali dei rifornimenti delle cucine di corte. Ancora oggi è famosa in tutto il mondo come uno dei più rinomati centri di produzione di pasta al mondo.
L'autore
Scritto il 25/10/2021



Lorena Calise
Il 25 ottobre è la Giornata Mondiale della Pasta, l’evento che celebra l’alimento più iconico della cucina italiana. Scopriamone di più insieme.